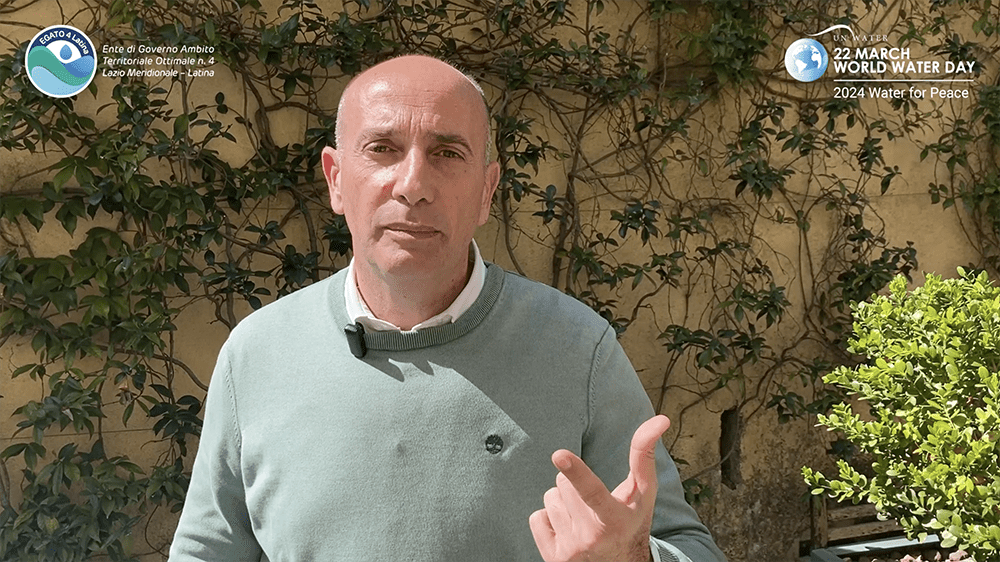Ogni anno, il 22 aprile, nel mondo viene celebrata la Giornata della Terra, un evento dedicato a sensibilizzare e promuovere la protezione nei confronti del nostro pianeta, con particolare attenzione alla sua sostenibilità. Anche per il 2024, il sito ufficiale earthday.org ha scelto e pubblicato il tema centrale dedicato alla giornata: “Planet vs. Plastics”, un richiamo all’importanza del corretto utilizzo e, soprattutto, smaltimento delle plastiche sul nostro Pianeta.
“Planet vs. Plastics”: come può vincere il nostro Pianeta?
Il tema di quest’anno, scelto dall’Earth Day Network, è “Planet vs. Plastics” (Pianeta contro Plastica). L’inquinamento plastico, infatti, minaccia la sostenibilità della Terra e, con lei, delle specie viventi che la abitano. Si pensi solo che, dei 7 miliardi di tonnellate di rifiuti plastici che sono stati prodotti finora a livello globale, solo il 10% è stato riciclato correttamente.
Un rischio, questo, che si ripropone anche sulle risorse idriche presenti nel Pianeta. Ad oggi, si contano circa 50 trilioni di particelle microplastiche nei nostri oceani, un numero che super di almeno 500 volte le stelle nella Via Lattea!
Parlando di plastica, non possiamo, dunque, ignorare il ruolo cruciale che questa gioca sull’acqua e sul suo ecosistema. Le risorse idriche sono fondamentali per la vita sulla Terra, ma sono sempre più minacciate dall’inquinamento plastico. Secondo le proiezioni degli stock ittici per il periodo 2015-2050, le plastiche supereranno il numero di pesci nei nostri oceani, influenzando la catena alimentare di numerose specie – tra le quali, anche quella degli uccelli marini: il 99% di questi, entro il 2050, ingerirà quotidianamente plastica.
Una nostra responsabilità
Ogni azione conta: dalla riduzione dell’uso di bottiglie di plastica all’adozione di prodotti riutilizzabili, possiamo tutti contribuire a ridurre l’impatto della plastica sull’ambiente e proteggere le nostre preziose risorse idriche.
Sebbene negli ultimi 20 anni il riciclo di plastica sia cresciuto di tre volte tanto (nel 2000 era solo del 3%, a fronte del 10% odierno), dobbiamo impegnarci per un uso più consapevole di questo materiale: ancora oggi, a livello mondiale, vengono acquistate un milione di bottigliette d’acqua ogni minuto.
Le piccole azioni contano! Per un cambiamento reale, serve l’appoggio di ognuno di noi.